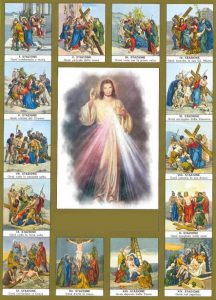Carissimi Parrocchiani,
abbiamo visto le difficoltà di Mosè di fronte alla chiamata di Dio. Alla fine, però, accetta, si affida e decide di ritornare in Egitto. Va dal suocero e lo informa: “Lascia che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!” (4,18).
Così, a distanza di quarant’anni, dopo un tentativo andato a vuoto, riprende la ricerca dei suoi fratelli. Eppure, quale differenza tra questa ricerca e la prima. Allora si trattava di un intervento generoso frutto della sua iniziativa, un po’ ingenuo, forse anche un po’ presuntuoso, fatto da un giovane, pieno di energie. Adesso, invece, è la missione che egli, uomo maturo e anziano, affronta solo perché Dio gliela affida.
Ed ecco le sorprese che Dio gli riserva. Anzitutto, l’incontro con il fratello di sangue, Aronne. Tutto si svolge secondo quanto Dio aveva preannunciato: egli sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te” (Es. 4,14-16). E così avviene: (Aronne) andò e incontrò (Mosè) al monte di Dio e lo baciò. 28Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l’aveva accreditato. 29Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. 30Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè (Es. 4,27-30) Dunque, Dio improvvisamente, in modo inaspettato, mette al fianco di Mosè un ‘fratello’: sarà il suo sostegno e gli permetterà di superare qualunque imbarazzo.
Una seconda sorpresa Dio riserva a Mosè ed è l’incontro con i fratelli. Il testo riferisce che la reazione del popolo di Israele alle parole che Aronne pronuncia in nome di Mosè è stata del tutto positiva: Il popolo credette (Es 4,31). Anzi, si precisa che gli israeliti, quando udirono che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono (Es 4,31). Contrariamente a quello che Mosè aveva temuto (“non mi crederanno”, Es 4,1)) il popolo credette. Dunque, Mosè deve ricredersi e riconoscere che Dio lo ha preceduto e ha già arato il terreno ancora prima che abbia ad iniziare la sua missione. Questo precedere è una caratteristica tipica dell’agire di Dio: la sua iniziativa viene prima della nostra opera, come rimarca bene P. Stancari nel suo commento:
(Mosè) non ha ancora cominciato il suo viaggio verso i suoi fratelli, che già questi – nella persona di Aronne – gli muovono incontro. Mosè si trova ancora presso il “monte di Dio”; ed in quello stesso luogo lo raggiungono i suoi fratelli, che scambiano con lui il “bacio” dell’amicizia e della pace. Man mano che l’impegno missionario di Mosè andrà prendendo corpo nei fatti, in riferimento alle situazioni concrete, egli sarà costretto a constatare di essere ogni giorno scavalcato dall’iniziativa di Dio che lo previene. Per chi è veramente chiamato al servizio dei propri fratelli, tutto accade come a gente sorpresa da un dono: quando forse ci sta predisponendo a qualche grande impresa apostolica ecco che ci accorgiamo, pieni di meraviglia, che i nostri fratelli sono già accanto a noi, […] uniti a noi dalla comunione che il Signore dona agli uomini, chiamati ad un’unica salvezza (P. Stancari, Lettura spirituale dell’Esodo, p. 49).Don Luigi Pedrini